C’è stato un tempo in cui il folklore era considerato roba vecchia. Roba da cartolina, da sagre di paese, da studenti fuori sede con la chitarra. Poi è arrivato Roberto De Simone, che si è spento lo scorso 6 aprile all’età di 91 anni. Musicista, regista, compositore, ricercatore, mente radicale. Ma più di tutto: uno che ha capito che dentro le voci delle processioni c’era una forma di avanguardia. E ci ha costruito una carriera. Una poetica. Una scuola.
Alla fine degli anni ’60, De Simone fonda insieme a Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò e altri la Nuova Compagnia di Canto Popolare. L’idea è semplice ma visionaria: recuperare canti e strumenti della tradizione orale campana e del Sud Italia, non per musealizzarli, ma per renderli nuovamente urgenti. Risultato? Un suono che nessuno aveva mai sentito, ma che tutti ancestralmente già conoscevano. Tamburi a cornice, zampogne e voci che non cantano, ma invocano. Sembrava musica uscita da un film di Pasolini ambientato in un presepe disturbato. Eppure, il pubblico — prima diffidente, poi rapito — capì che in quel ritorno alle radici c’era qualcosa di autentico e necessario. Non era nostalgia. Era militanza culturale.
Andate a riascoltarvi il Secondo coro delle lavandaie, canto popolare riadattato da De Simone per l’opera La gatta Cenerentola. Qualche anno fa ero in macchina con amici, e l’imprescindibile modalità randomica di Spotify fece partire questo brano. Un amico DJ dal sedile posteriore urlò: “ma questa è techno hardcore”. Non conosco altro modo per restituirvi l’immagine di Roberto De Simone se non attraverso questo aneddoto. Ma c’è dell’altro.
Il Secondo coro delle lavandaie riprende i canti che risalgono addirittura al 1400, quando le donne che lavavano i vestiti al fiume cantavano e portavano il tempo sbattendo gli stracci bagnati. E nel farlo cantavano dei loro sogni e delle loro ambizioni. Cantavano, ad esempio, del sogno sogno erotico dell’essere possedute dal Re, prima di essere svegliate “sul più bello”. È la medesima origine, se ci pensate, del blues negli Stati Uniti, nato dagli schiavi delle piantagioni di tabacco che cantavano per sopportare meglio la fatica.

Nel 1973, Roberto De Simone mette mano agli arrangiamenti del primo album di Eduardo Bennato, Non farti cadere le braccia. Un lavoro che oggi potremmo definire proto-folk partenopeo. Là dove Bennato portava il folk-rock, De Simone innestava contrappunti colti e suggestioni arcaiche. Un’alleanza atipica, ma perfetta. Il lato B del disco si chiude con una canzone bellissima che si chiama Rinnegato. Un brano nel quale Bennato cita e omaggia tutti i suoi più stretti collaboratori (e tra questi anche lo stesso De Simone).
“Avete letto mai Roberto De Simone?
Ha fatto lungo viaggio nella tradizione
Lui dice che in Italia col passar degli anni
la musica va indietro e non si va più avanti”

Nel 1976, De Simone scrive e mette in scena la già citata opera La Gatta Cenerentola, ispirata a una fiaba di Giambattista Basile. Un cortocircuito tra colto e popolare, tra seicento napoletano e sensibilità contemporanea (e per quel mio amico addirittura tra tammurriata e techno). Dentro ci ritrovi l’eleganza barocca, il canto femminile come strumento e il napoletano come lingua d’arte. Ma soprattutto, trovi un’idea di teatro musicale che in Italia non esisteva: né opera lirica, né musical, né cabaret. Una cosa sua.
Tra le perle dimenticate della discografia di De Simone vale la pena di citare Il gioco del cavallo a dondolo, traccia macabra e oscura contenuta all’interno dell’album Io Narciso io. Uscito nel 1977 per la RCA, è un lavoro cupo, disturbante, difficile. Quasi inascoltabile per i canoni dell’epoca. Per molti anni è stato un pezzo introvabile finanche nel mare magnum del web. Sembra lo stile lirico di Tenco. Se Tenco fosse cresciuto a Somma Vesuviana però. La storia di un uomo, dall’infanzia al suicidio, che racconta le turbe della propria psiche con un linguaggio da bambino, tra cavalli a dondolo e istinti omicidi. Non è roba da playlist.
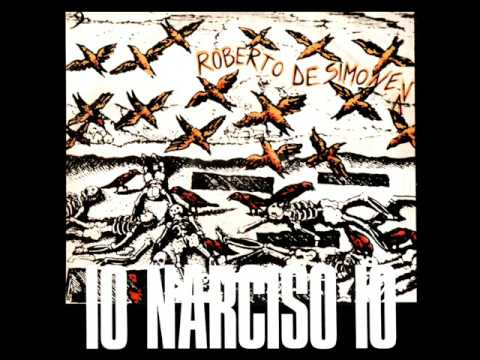
Ci sarebbero tante altre cose da dire su Roberto De Simone. È stato direttore del Conservatorio di Napoli, del Teatro San Carlo, autore di saggi sul presepe napoletano, sul culto delle anime del Purgatorio, sulla teatralità popolare. È stato artefice di un linguaggio che non ha mai cercato il consenso, sebbene abbia sempre raccolto rispetto. Cosa resta? Resta una lezione. Che non esiste tradizione senza visione. Che si può essere contemporanei tornando indietro. E che sì, si può far tremare un palco senza una chitarra elettrica. Basta una tammorra. O anche solo un silenzio, se sai dove metterlo. Roberto De Simone sapeva farlo.
---
L'articolo Roberto De Simone ha fatto suonare il passato come fosse il futuro di Marco Brunasso è apparso su Rockit.it il 2025-04-08 16:50:00


COMMENTI