I nostri cuori, in guerra o arresi, tra l’amore, il coraggio e la paura.
Ho un cuore che, col passare degli anni, diventa sempre più incline a derive romantiche e si interroga spesso, che aspira a sentimenti durevoli ed eterne conquiste, e come negargli simili ambizioni se questo è ciò che rimane dopo lotte interminabili, lente peregrinazioni attorno al medesimo punto che si concludevano con notti insonni. Quasi che la mia vita potesse dividersi in segmenti d’amore e di paura, instabili e vaghi, mai netti nelle posizioni prese verso te, mai chiare nei baci dati e ricevuti, e nelle parole che ci scambiavamo dando loro ogni volta significati differenti.
Passano gli inverni e ci si ritrova nella stessa stanza coi dischi dei Non Voglio che Clara, dischi che ho sempre immaginato adatti ad una stanza, a un posto delimitato e invisibile agli altri se non a noi, tra i racconti che poi sono i nostri, le battaglie tra l’avvicinarsi e il perdersi, la scintilla negli occhi e l’assopirsi dei fuochi, e le continue domande di due cuori affaticati: e da un disco all’altro, fino a “L’Amore Fin che Dura” che sembra aprire le finestre di questa stanza, spalancarle ad aria profumata e leggera a volte, altre al volto grigio dei giorni ricurvi su un errore, ma è pur sempre aria, è movimento, è la possibilità di affacciarsi e guardare fuori, altre persone, altri mondi, ulteriori cuori più o meno ammalati, in guerra o arresi, tra l’amore e la paura.
Le trame si arricchiscono di venature sintetiche, di abbracci pop e sapori contrastanti, il sorriso e l’amarezza, gli archi e i fiati e la profondità di storie raccontate con solita maestria: il racconto è il senso di tutto, l’anima dei Non Voglio che Clara, il racconto al quale non sfuggi mai, che segui con l’attenzione che spesso non mi dai, in cui non fai fatica a riconoscerti e, come l’adolescente che non smetti di portarti dentro, credi che t’appartenga e lo canti in auto, da solo, in quegli istanti che sono soltanto tuoi, ed è bellissimo. E il racconto attraversa i rapporti a due, dove l’altro è qualcuno che hai amato, o che ami ancora in modo diverso. Qualcuno che ti ha tradito o che ti consola, qualcuno che semplicemente ascolta, e il centro nevralgico sta nel passo fatale che segna il confine tra passato e futuro: in diversi brani pare proprio di trovarsi in quel punto lì, in bilico, con occhi capaci di vedere chiaramente indietro e difficilmente avanti, trattenuto in un presente critico dall’incapacità di rompere schemi seppure ormai stancamente ripetitivi e soffocanti.
Le relazioni umane attraversano “Il Complotto”, ed è come se qualcuno ti osservasse dall’alto riuscendo a guardare fino in fondo, giù, dove conservi i segreti e i cambi d’umore, dove fai sempre confusione, e celi le notti agitate dietro uno sguardo imperturbabile, uno sguardo che corre per cercare “fra le pieghe di un letto disfatto, fra gli stampi sul cuscino e le lenzuola, un lato intatto”, e in quella ricerca c’è tutto: l’ansia, il terrore, il sentimento profondo, e ci immaginiamo la scena immergendoci tra le trame orchestrali immediate e impalpabili che ti afferrano sin dall’inizio, ed è un gioco di pianoforte, archi che scivolano e infinitesimi effetti, è l’ultimo lento tra luccichii sinfonici e la poesia che insegui. “Le Mogli” celebra il coraggio mancato, l’abitudine, certe cicliche quotidianità che diventano veleno, scandita come un battimano e con quel piano che non si perde mai, per giungere a un finale che possiede il mood da gospel choir, tra innesti vocali e un crescendo sonoro che sa quasi di gioia: e allora vendiamoci il cuore in cambio di una nave, il cuore, affaticato e dalle mille domande, e dalle mille scuse di “Le Anitre”, finite in fretta, affogate in atmosfere malinconiche e nei suoni che paiono sul finire il montare dell’oceano, e in quel “tu non sei così pronto con tutto che te l’aspettavi” che racchiude l’attimo stesso in cui sai che una storia è finita ma sei lì, in bilico, con occhi capaci di guardare solo l’attimo stesso e poi nient’altro.
E così ci ritroviamo immersi in una sorta di epopea western con “Gli Acrobati”, che d’emblée mi riporta a “In Un Giorno Come Questo”, con quel giro di chitarra che ricorda cavalcate su terreni brulli con occhi pesti e fiato sul collo, e nei fiati racchiude un episodio triste, e vere e proprie lacrime negli archi, e una assoluta verità che ci appartiene: “Tu questi pensieri non li hai, tu non ci pensi mai a quello che vorrei ma che non sono, a quello che non sei”, e ci si perde nei ricordi, di chi nonostante la distanza rimane così vicino da condizionare tutto. E che bella “La Sera”, lieve, abbracciata al tramonto dei pensieri più scomodi, all’assenza di chi vorresti ancora, che rimanda al cantautorato elegante d’antan e assume tinte solari con quel tappeto di suoni ricamato con dolcezza: è esattamente la finestra che si apre sulle nuvole rosa e arancio e so, in quel momento, che non ho smesso di cercarti, fosse pure soltanto nei pensieri che restano mentre il giorno finisce.
Il coraggio che manca ritorna in “L’Escamotage”, e lo sai, “Ho il difetto di insistere, l’abitudine a perdere”, e tra un amore logoro e la paura di domani continuo a non scegliere, tra trame che si fanno elettroniche e cupe, e portano addosso il freddo asciutto di piccole incursioni psichedeliche, e nel freddo insostenibile del brano più triste, continuo a galleggiare in quella quotidianità che diventa veleno, quella presa ordinaria che t’uccide come in “Lo Zio”, morbida ballata malinconica che stilla consapevole amarezza; e l’episodio solare e ironico di “La Bonne Heure” sembra spezzare per poco l’intensità, una intensità che amo e che temo, e che cede al suono sottile di “I Condomini”, minimale nella voce e negli accordi e che spinge a pensare a vecchi cantautori introversi e nostalgici, e distendiamo i nervi, e chiacchieriamo un po’ che aiuta, ché “se mi parli di una dieta o dei difetti di uno smalto, con le unghie, con i denti mi attacco ai tuoi di fallimenti e scopro di non esser così stanco”, e la nostra stanza piano cambia colore tra le luci che si accendono, e le scintille negli occhi, e l’assopirsi dei fuochi. E con “La Caccia” ritrovare la paura, e rifugiarsi nella distanza, e tentare infine di capire se il coraggio sia davvero nell’andare via, questo coraggio barbaro che, sospeso tra te e me, finirà per distruggerci, in un’esplosione di suoni inattesa e che va giù dritta nello stomaco per poi chiudersi come in un requiem con una prolungata nota d’organo.
Prodotto insieme a Giulio Ragno Favero, “L’Amore Fin che Dura” è il gusto per soluzioni raffinate e omaggi a chi nel tempo ha avuto il medesimo gusto, è la scrittura dritta e pulita e perfetta fatta di quelle che a me sembrano costellazioni sintattiche luminose e disegnate con incantevole cura, cose a cui la band ci aveva largamente abituato, con l’aggiunta di arrangiamenti più ricchi, accenni elettronici e certe strutture leggere che già comparivano in “Dei Cani” e qui acquistano spazio, le finestre di cui parlavo, nella stanza dove passavamo gli inverni ad ascoltare dischi, tra l’amore, il coraggio, la paura e quei traguardi ancora lontanissimi.
---
La recensione L'amore fin che dura di Scritto da Giulio Pons è apparsa su Rockit.it il 2014-01-27 00:00:00


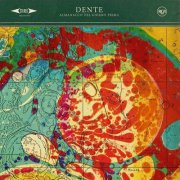


COMMENTI (2)
bello. bravi. bis.
bellissima recensione! e bellissimo disco, non deludono mai.