Sole a picco, strada vuota, trascini i piedi uno dietro l'altro, non un edificio nelle vicinanze, non una macchina. Il deserto? Forse, sì, anche. Le allucinazioni? Decisamente sì. E anche se quella piantina che scorgi ha tutta l'aria di essere peyote non è detto che lo sia davvero, e soprattutto non è detto che tu ne abbia bisogno. Ancora. Quel che conta è continuare a camminare. Anche se le gambe non le senti più, e la sete ti divora. Anche se hai ormai smesso da ore di guardarti indietro nella speranza che passi un camion a tirarti su. Anche se non ti ricordi nemmeno più come ci sei finito, su questa strada. Sono ben altri i pensieri che ti tormentano, mentre continui a camminare, un po' per istinto di sopravvivenza un po' semplicemente per inerzia.
Sì, ok, ho finito, se volete la prima parte la potete anche skippare, se vi stancate a leggere cose troppo lunghe e che non vanno dritte al punto: ma un disco come questo è impossibile non raccontarlo con le suggestioni. Perché di queste si nutre, e per converso nutre l'ascoltatore, scrivendo attraverso i suoi malinconici arpeggi di chitarra e l'inquietudine del violino una storia che possiamo solo immaginare. Ma senza fatica.
E con la voce roca, marcia, scurissima di Paolo Bertozzi, che fa pensare a quella dell'ultimo
Johnny Cash, e le atmosfere che si muovono tra folk desertico, neopsichedelia (uno dei primi amori dei 2Hurt) e il
Dylan più buio e sconfitto, un Dylan che torna in tante sfaccettature, non ultima la decisa presenza del violino, che tanto ricorda quello di
Scarlet Rivera in "Desire". Con i riff di chitarra a tagliare il vento, un vento che potrebbe soffiare tanto verso casa ("Find my way back home") quanto condurre in un vicolo cieco ("Young suicide"). O lasciarti lì, sul ciglio della strada, perso tra i rimpianti ("Without affection", magnifica).
Ci sono ricascato: è davvero difficile parlare di "On bended knee", sesto album dei romani 2Hurt, senza lasciar correre l'immaginazione. Ma provo a tornare per un attimo tra noi: la band è attiva da diversi anni, ma io l'ho scoperta l'anno scorso, col bellissimo disco strumentale "Mexico City Blues", ispirato a Jack Kerouac e con la partecipazione di Van Christian, mostro sacro del Paisley Underground.
E se quello era già un disco sorprendente, questo nuovo segna uno scarto ulteriore, e per quanto mi riguarda la mia personalissima classifica (di cui è giusto è legittimo che non vi possa fregare di meno) potrebbe addirittura essere l'album italiano dell'anno. E ora che ho finito di parlar chiaro, scusate, lo faccio ripartire. Torno sotto il sole a picco, a trascinare i piedi.

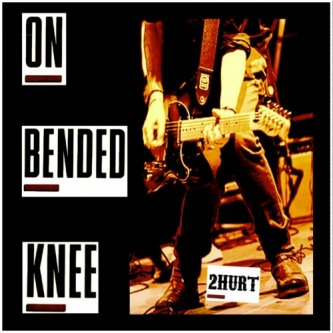


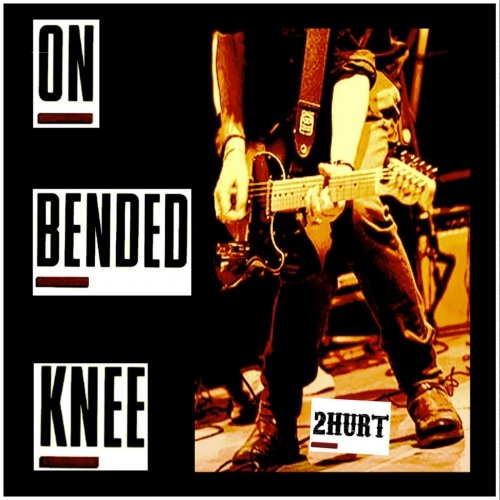
COMMENTI (1)
Capolavoro ottima recensione