Secondo disco per Lay Llamas. Nel segno della psichedelia cosmica e non solo.
Thuban è una stella che indica il Polo Nord. Aveva un ruolo assai importante tra chi, qualche secolo or sono, prendeva la via del mare: tant’è che bastava individuarla per non perdersi e navigare in tutta tranquillità. Una sicurezza, una delle poche concesse tra i tanti pericoli offerti dalla minacciosità delle acque. Quattro anni fa, Lay Llamas, progetto la cui titolarità è da ricondurre a Nicola Giunta, si fece conoscere con “Østro”, nient’altro che il nome di un vento, che ben conoscono dalle parti del Mediterraneo del Sud. È evidente che gli elementi tribali continuino a rivelarsi essenziali per Lay Llamas, per la sua scrittura, per il suo modo di interpretare la psichedelia. Che non è un monolite da difendere né da contemplare a distanza. E nemmeno un dogma da rispettare in modo assoluto. Psichedelia è creatività e libertà di accesso tra i chakra dell’anima. Una lezione che il musicista siciliano ha assorbito in tempi non sospetti.
“Thuban” è l’evoluzione di “Østro”, è il suo fratello maggiore, quello più maturo, quello che ti convince a lasciare da parte l’istintività e a riflettere. Lo stesso Giunta, nell’intervista che ci ha rilasciato qualche settimana fa, parla di un esordio “selvatico, istintivo e naïf”. Quattro anni più tardi, il suono è più ragionato, se vogliamo, più morbido. Senza però arrivare ad archiviare quegli elementi cosmici e, ripetiamo, tribali che disegnarono le coordinate dell’opera prima. “We come from lands with no time, traveling to peace of mind. Holy brew, sonic dawn, and we’ll drink the kykeon once again”: l’attacco del testo di “Chronicles from the fourth planet” rende bene l’idea dell’aria che si respira all’interno dell’album.
“Eye-chest people’s dance ritual”, con la parte ritmica a riempire lo spettro sonoro e la chitarra di Nicola Giunta a sostenerne l’impalcatura, è l’inizio di un itinerario che schizza verso altre direzioni sin da “Holy worms” e il suo substrato di derivazione afro-beat. Con “Silver sun” siamo alle porte del cosmo che stanno su in Germania (i Neu!), il sax di Sergio Pomante (Ulan Bator) si lancia alla conquista di chissà quale galassia e squarcia l’anima con le sue spezie free jazz. “Rites from the black cliff”, suonato assieme ai Clinic è ipnotico, lisergico, quasi meditativo, “Altair”, nonostante la tastierina proto floydiana, potrebbe definirsi un pezzo pop, la voce di Goatshee dei Goat regala ulteriori ciliegine su di una torta già di per sé sontuosa. Altro ospite di lusso in “Fight fire with fire”, si tratta di Mark Stewart dei Pop Group, una sorta di spoken-word cupo, pieno di tenebre, ben piazzato in compagnia della già menzionata “Chronicles from the fourth planet”, mantra immerso in atmosfere medio orientali, mentre la conclusiva “Coffins on the three, a black braid on your way to home” è lenta e ipnotica, con un crescendo percussivo ossessionante. Il totale è pari a un album dal quale emergono dosi massicce di psichedelia cosmica, kraut rock, viaggi su autostrade interstellari. Viaggi che ti fan sentir bene.
Un disco che nel Regno Unito racchiuderebbero nel filone “Italian occult psychedelia”, ma che proprio gli inglesi hanno fatto proprio grazie alla Rocket Recordings, etichetta che ha preso tra le proprie ali protettive “Thuban”, così come aveva fatto quattro anni fa con “Østro”. A confermare che la Rocket ha l’occhio lungo e che non sbaglia mai. Nemmeno questa volta.
---
La recensione Thuban di Scritto da Giulio Pons è apparsa su Rockit.it il 2018-08-06 09:00:00

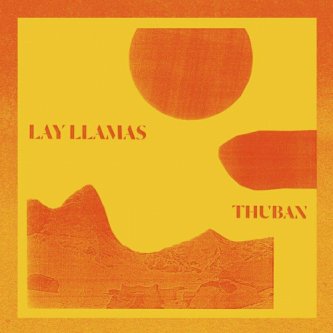


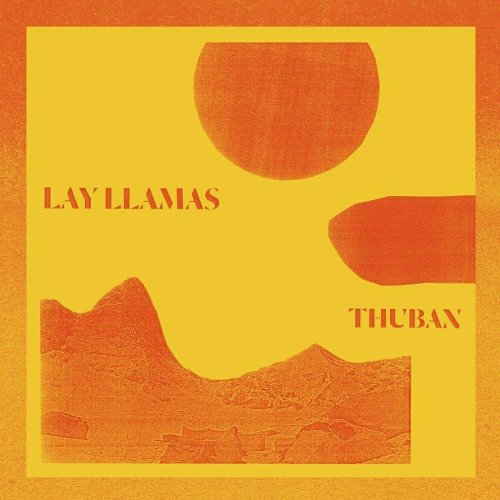
COMMENTI